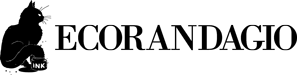Probabilmente, l’impotenza è il sentimento più comune che si possa provare dinanzi alla guerra. L’atavico conflitto Israele – Palestina continua a generare violenza, sangue e morte. Dal 7 Ottobre 2023 da parte di Hamas sono stati uccisi 274 militari e 859 erano civili. Le persone prese in ostaggio sono circa 250, tra cui anziani, ragazzi e bambini. Il bilancio delle persone uccise lungo la striscia di Gaza sale a 36 mila. Sta verificandosi da mesi una carneficina, uno sterminio, un crimine di guerra. Eppure c’è qualcuno che evita di utilizzare questi termini, a conferma del fatto che non tutti sono testimoni della storia. Chi lo è, però, si chiede come poter essere d’aiuto. Un modo c’è: utilizzare la parola come antidoto alla guerra.
Fare parola e farsi pensiero di fronte alla guerra
Le immagini del massacro israeliano-palestinese che sta avvenendo in questi mesi, lasciano attoniti. Questo terrificante conflitto che coinvolge i civili si sta verificando in luoghi non così distanti dall’Occidente industrializzato. In molti infatti si chiedono: “E se la guerra esplodesse anche qui?”, “Se scoppiasse una terza guerra mondiale?”. Tuttavia, fossilizzarsi sul rischio che la guerra possa espandersi non serve, poiché se davvero si vuol fare qualcosa di utile bisogna parlarne. Non stare in silenzio, mai. Non rincantucciarsi nell’ignavia, ma urlare, scendere in piazza, manifestare contro i crimini di guerra. Ché questo conflitto ci riguarda tutti, non esistono confini territoriali quando si tratta di vite umane.
Esiste piuttosto la responsabilità di farsi portavoce di ingiustizie e di essere testimoni della «Resistenza». Per non sentirsi impotenti bisogna costruire uno spazio di dialogo e di lotta, uno spazio di vita che contrasta le linee di morte. Fare parola e farsi pensiero di fronte alla guerra significa raccontare quello che sta accadendo, essere informati. Vuol dire ricordare (“Meditate che questo è stato” – Primo Levi) quanto male è stato perpetrato in passato ai danni dell’umanità e non lasciare che la memoria caschi nell’oblio. Ché l’oblio raffigura il male, mentre la memoria è carne, è fuoco che non ha smesso di ardere.
Per combattere l’impotenza occorre scegliere da che parte stare. Per farlo non serve necessariamente andare sul fronte di guerra, mettersi in trincea. È ovvio che, chi oggi è al riparo da questa guerra, voglia tenere lontana l’idea che il conflitto possa arrivare anche qui, dove c’è (apparentemente) pace. Per farlo può servire informarsi, interrogarsi, cercare spazi sul web che parlino di quello che sta accadendo in Palestina. Occorre ricordarsi di quanto sia preziosa la libertà e che essere liberi implica anche occuparsi di chi libero non lo può essere.
Liberi lo siamo diventati grazie alla Resistenza, grazie all’impegno civile, grazie a chi ha lottato – rimettendoci la pelle – per la democrazia, per la riappropriazione della dimensione giuridica e morale degli individui.
Primo Levi ci insegna che bisogna tenere bene a mente il connubio identità-dignità: per vivere occorre un’identità, ossia una dignità. L’identità si compone di un Sé che non nega il conflitto, ma che lo accetta perché parte ineludibile dell’esistenza. Un Sé conscio delle brutture che gli uomini sono capaci di compiere a discapito di noialtri. Bene, questa identità che fa esperienza del dolore, deve ricordarsi che non ha ragion d’esistere senza dignità. E dignità – chiosa Primo Levi – esige che nulla sia concesso al disumano che dilaga.
Intanto, a distanza di un secolo la disumanità continua (eccome) a dilagare. E noi (in tanti si chiedono) cosa possiamo fare per renderci utili?
Può sembrare poco, riduzionistico, ma già parlare di questa disumanità è un passo, rende agenti, dispiega distese di luce su zone di ombra. Zone grigie che necessitano di essere raccontate da chi oggi ha il privilegio di non essere in quelle zona di guerra. Privilegio non vuol dire voltare lo sguardo, anzi significa essere generosi, sgranare bene gli occhi sull’orrore, alzare la voce e farsi messaggeri di memoria. Ovvero, diffondere il messaggio che la storia non è stata dimenticata e che in nome di quella stessa memoria, in nome di quel vulnus, nessuno potrà mai tacere dinanzi alla guerra. In nome del passato serve urlare ogni giorno il «cessate il fuoco».
Perché è così rivoluzionaria la parola?
Se osserviamo la guerra dal punto di vista psicologico, è possibile riflettere sul contrasto Causa – Legge, Male – Bene, Irrazionalità – Pensiero. Forze contrarie che si battono da tempi remoti.
A proposito di queste antitesi, nel libro “I tabù del mondo”, lo psicoanalista Massimo Recalcati, affronta il tema dello “spirito del terrorista”. Quel che scrive ci offre suggerimenti circa la Causa che anima il terrorista, Causa che annienta la parola.
Lo spirito del terrorista, infatti, non crede nella legge della parola, perché l’unica cosa che conta è la Causa.
“Il terrorista non agisce in nome del proprio Io, ma in quello dell’Ideale al quale si consegna anima e corpo. Egli agisce senza paura della morte perché non conosce il tarlo del dubbio. Il terrorista non è un soggetto diviso, la sua coscienza non è tormentata, il suo essere è compatto, granitico, roccioso, duro.”
Dunque, chi si fa esecutore del terrore e della morte non è abitato dal senso di colpa, perché è mosso solo e unicamente dalla Causa (razza, orientamento politico, religione, territorio, ecc). L’apologetica della Causa può essere contrastata solo attraverso la parola, perché il terrorista – come afferma Bion – è privo di mente e di pensiero. Egli è disposto a immolare la sua vita pur di difendere la sua folle verità assoluta.
Ecco perché in questo tempo di guerre e di conflitti sanguinosi, la parola è rivoluzionaria. Chi osanna il terrore, le armi, i bombardamenti è anestetizzato dal sentire. Non sente emozioni, né dolore. È la «freddezza umana» – osserva Recalcati – a caratterizzare l’azione del terrorista.
E allora fare parola e farsi pensiero è l’unico espediente possibile per far vacillare questa freddezza. Se facciamo instancabilmente uso della parola non siamo impotenti. Siamo potentissimi.
Se ti è piaciuto, leggi anche:
- Cosa resta di Auschwitz oggi?
- All eyes on Rafah una storia su Instagram condivisa da 38 milioni di persone
- Dalle passioni tristi alle passioni gioiose