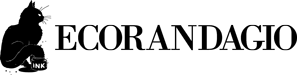In questa intervista, un’insegnante ci spiegherà com’è stato lavorare al carcere minorile di Nisida.
Quando hai iniziato a lavorare al carcere minorile di Nisida e che lavoro svolgevi?
Ho lavorato nel carcere minorile di Nisida dal 2004 al 2008. Nonostante l’età superiore ai 13, questi ragazzi frequentavano le medie. C’erano ragazzi anche di 18 anni (l’età massima per essere nel carcere minorile) e nessuno proseguiva con il liceo dopo. Seguivano le lezioni per 3 ore al giorno, dalle 9 alle 12. Le materie erano italiano, matematica, tecnica e inglese. Io insegnavo inglese. La maggioranza dei ragazzi era italiana, altri invece erano di etnia Rom o di altre provenienze. Le ragazze erano separate dai ragazzi.
Come è stata la prima volta che hai messo piede nel carcere?
È stata una brutta esperienza. Ricordo di aver varcato il primo e poi il secondo cancello per entrare nel carcere. Quando si chiuse l’ultimo cancello fece un gran rumore e io, al sentirlo, mi misi a piangere perché avevo capito dove mi trovavo, cioè in un luogo pieno di ragazzi senza libertà. Erano ragazzi che potevano essere figli miei. Mi resi conto che lì dentro c’erano delle vite che chissà se sarebbero tornate ad essere belle vite. Piansi all’idea di dover cominciare la mia giornata lì, in quell’isola che è meravigliosa. C’è l’inferno dentro, però è bella come isola.
Vi era dato sapere perché i ragazzi si trovavano lì dentro?
Si sapeva, ma si cercava di non saperlo, per evitare reazioni. Era meglio starne fuori. I più erano rapinatori o spacciatori, poi c’era chi aveva commesso crimini più gravi. Si sapeva quando arrivavano spacciatori, mentre non si sapeva quando arrivavano stupratori. Tra ragazzi, invece, probabilmente si sapeva sempre.
Com’era l’ambiente lavorativo?
L’ambiente era tranquillo perché avevamo sempre le guardie carcerarie fuori dalla porta. C’era il massimo rispetto per noi insegnanti e non potevano fare altrimenti. La scuola almeno serviva loro per distrarsi. Infatti, la mia collega di italiano ha convertito Nisida in un’isola letteraria. Lei ora è in pensione ma, quando insegnava lì, faceva scrivere ai ragazzi delle storie dando loro un tema. Spesso invitava scrittori da fuori, a volte si trattava di scrittori di fama nazionale. Sono stati assegnati dei premi per i loro scritti anche ai ragazzi. Inoltre, i ragazzi erano occupati con laboratori di cucina, ceramica e di falegnameria nel pomeriggio.
Fare lezione con loro era diverso che fare lezione con ragazzi fuori dal carcere?
Era molto diverso, bisogna partire dal presupposto che molti di loro erano analfabeti. C’erano dei ragazzi cinesi quando c’ero io, e ricordo che con loro fu difficile risolvere il problema della lingua. Parecchi di loro non sapevano scrivere perché non avevano frequentato le elementari. Io con l’inglese facevo quel che potevo.
Ti sei mai trovata in situazioni spiacevoli?
Una volta sola e fu una brutta esperienza, non era mai capitato. Avevamo appena cominciato a fare lezione ma io non mi ero accorta della situazione che si stava venendo a creare: fra di loro si parlavano a bassa voce, ad un certo punto volarono il tavolo e le sedie e alcuni di loro cominciarono a picchiarsi. Io per fortuna ero verso la porta, se invece fossi stata verso la finestra mi sarei presa anch’io le botte. Chiamai aiuto e subito la guardia carceraria entrò per dividerli, ma fu colpito anche lui al braccio. Le mie colleghe vennero subito a prendermi, mi portarono fuori e mi tranquillizzarono. Quello che non riesco a dimenticare di quell’episodio è la violenza che esprimevano quei ragazzi. Loro furono messi in isolamento e, nel periodo in cui ho insegnato lì, una cosa del genere non è più successa.
Rispetto ad insegnare in scuole con realtà difficili, com’era insegnare in un carcere?

La differenza era che in carcere eravamo protetti. Anche nelle scuole regolari possono succedere episodi di violenza, ma non c’è nessuno a proteggerti.
Quanto cambia la situazione dei ragazzi, dopo essere usciti dal carcere?
Si fa di tutto per fare in modo che, usciti da lì, i ragazzi abbiano un’altra possibilità. Alcuni ne escono, altri sono talmente radicati nel sistema che non ne usciranno mai e, se ne escono, lo pagano. Ricordo che alcuni di loro mi dicevano: “Io non posso uscirne, se voglio uscire da questo sistema mi ammazzano subito”. Invece, un ragazzo che poi rincontrai in Vesuviana mentre andavo al lavoro, è riuscito a cambiare vita: quella mattina lui stava andando a fare un corso per diventare pizzaiolo. Lui si era ritrovato in carcere un po’ per sbaglio, era stato per un colpo di testa fatto con un amico, una rapina. Non aveva bisogno di fare atti del genere, era un bravo ragazzo, era stato trascinato da un compagno e l’ha pagata.
Ti è mai capitato di affezionarti particolarmente a qualcuno di loro o c’è qualcuno in particolare che ricordi con affetto?
Ricordo tutti con affetto. Specialmente le ragazze, che erano la maggior parte Rom. Una l’ho vista anche qui, nei dintorni di Castellammare, che chiedeva l’elemosina con un bambino in braccio che io sapevo non essere il suo: lei non aveva figli uscita da Nisida. Nei miei anni in carcere ho imparato che tra ragazze Rom è normale prestarsi i bambini per chiedere l’elemosina e impietosire i passanti. Lei stessa mi ha detto che quello non era suo figlio. In carcere capitavano spesso le ragazze madri. Ricordo un bambino che a otto mesi già mangiava cioccolata e beveva coca cola. Rimasi sconvolta a vederlo. Quando era entrato in carcere insieme alla madre, quel bambino era denutrito, riuscivo a vedere la scatola cranica. Le guardie carcerarie gli vollero subito bene e fecero in modo da farlo rimettere subito in forze. Era un bambino bellissimo.
C’era in loro la volontà di uscire dal carcere?
Quelli che commettono i crimini sanno esattamente a cosa vanno incontro, lo fanno perché fanno parte di quel sistema. Ragazzi che rubano perché sono “invidiosi” di quelli che hanno gli stivali di Paciotti: “Perché quelli li devono avere e io no?”, mi ha risposto uno di loro quando gli ho chiesto il perché della sua azione. Oppure mi rispondevano: “La vita mia è questa”. In molti di loro la voglia di uscire non c’era proprio. Non potrò mai dimenticare un ragazzo che a 16 anni aveva già una piazza di droga a Porta Capuana. Era avviatissimo. Mi ha chiesto quanto guadagnassi al mese, che a quel tempo erano 600 euro al mese per otto ore di lezione settimanali.
Mi ha risposto, in napoletano: “Chisti renari li facciò in mezzà iurnata”
È stata l’unica volta in cui mi sono permessa di giudicare, però glielo dovevo far capire, anche se poi queste mie parole non suscitarono alcuna reazione: “La differenza però qual è… tu stai dentro, io sto fuori”, gli ho risposto. Aveva due occhi azzurri, tipo Paul Newman, di ghiaccio. Facevano paura, quegli occhi, per la violenza di cui erano capaci. Era l’unico che mi faceva paura quando lo guardavo. Aveva lo sguardo di quelli che non si salvano e non si salveranno mai.
Era tranquillo, in carcere, questo ragazzino?
Non era un ragazzino, era un uomo, già aveva bruciato tutte le tappe.
Lui era tra quelli che entravano e uscivano o era sempre lì?
Era sempre lì. Altri invece uscivano, poi rientravano per gli stessi crimini. Rapine, spaccio. Questo ragazzo, mi dicevano le colleghe, era molto intelligente, perché non si drogava. Era freddo e aveva sempre il controllo della situazione. Ci sono quelli stupidi, che spacciano e si drogano, ma lui no. Lui era molto intelligente, ma ce n’erano molti così. Ricordo il figlio di un boss, che parlava benissimo l’inglese. Ai ragazzi così capita spesso di andare all’estero, specialmente nei paesi dove si parla spagnolo. La piazza è grande, a loro interessava molto imparare lo spagnolo.
Come si comportavano i figli dei boss?
A livello di comportamento, il figlio del boss era perfetto: si vedeva che c’era un altro tipo di educazione. Finivano in carcere per spaccio, però a grandi livelli.
Hai mai avuto tra i tuoi alunni ragazzi che hanno commesso omicidi?
Uno si, e finì anche al telegiornale. Era un bravo ragazzo, da cui non ci si sarebbe aspettati un gesto del genere. Fu per uno sguardo rivolto alla sua ragazza da parte di un altro ragazzo. Uno sguardo pagato con la vita. Piano piano quel ragazzo aveva capito quello che aveva fatto, era un bravo ragazzo. Chissà che fine ha fatto, spero che non si sia perso.
Cosa sapevi del rapporto che avevano tra loro i ragazzi?
Quasi nulla. Le colleghe mi ripetevano sempre di tenermi fuori dalle situazioni, altrimenti avrei potuto passare dei guai anche io. Noi insegnanti avremmo potuto lasciarci trascinare all’interno, cercare di salvare qualcuno, come era successo ad una collega molti anni prima. Lei aveva tentato di salvare una ragazza e fu denunciata per qualcosa che non ricordo. La stessa famiglia della ragazza non era d’accordo.
Secondo te le istituzioni stanno facendo un buon lavoro con questi ragazzi?
Il direttore del carcere di Nisida sta facendo un ottimo lavoro, sta dando spazio a qualsiasi iniziativa che possa dare voce a questi ragazzi, per dargli una seconda possibilità, un futuro.
Cos’altro hai imparato dopo aver lavorato in un carcere?
Quanto siamo fortunati.
Elsa Buonocore
Leggi anche Cosa sarebbe la mia vita senza un influencer