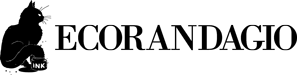Un tema fortemente discusso negli ultimi anni nelle comunità LGBT+ e nono solo e che trova terreno fertile in società come la nostra, in cui vi è perlomeno un margine di discussione sul tema del rispetto nei confronti delle minoranze, è quello del “rainbow washing”. In molti storceranno il naso dinanzi all’ennesima espressione di slang coniata per l’apposita circostanza, eppure l’ormai complessa realtà in cui viviamo richiede una altrettanto complessa spiegazione della stessa.
Il neologismo in questione fa parte del grande calderone del “wokewashing”
altro neologismo che rimanda alla pratica usata dai brand di sfruttare il grande tema della giustizia sociale come strategia di marketing. Detto ciò e constatata la presenza della parola arcobaleno (“rainbow”) nell’espressione celebre simbolo della comunità LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer/questioning, intersessuali, asessuali/alleati) si può trarre in maniera semplice la definizione.
Si tratta della strumentalizzazione delle tematiche LGBT+ da parte dei marchi con l’intento di simulare una realtà “gay friendly”, aumentando così il consenso presso i consumatori e, di conseguenza, le vendite. Dal momento in cui non si parla di creare inclusione, bensì un’apparenza di inclusione, la preoccupazione che i brand possano rappresentare la comunità superficialmente, contribuendo a rafforzare stereotipi nocivi per essa è molto alta.
Ma tale preoccupazione puòessere ancora motivata al giorno d’oggi? LA COMUNITÀ LGBT+ NELLE CAMPAGNE PUBBLICITARIE DI OGGI
Ecco la scena: due omosessuali si incontrano in un locale, in pochi minuti scelgono di abbandonare i drink per recarsi a casa, la situazione si scalda e dallo spot risulta evidente che non hanno minimamente pensato ai preservativi. Il tutto, accompagnato dalla voce narrante di un gorilla dall’insolito pelo violaceo che pare predire ironicamente ogni singola mossa dei nostri protagonisti. È vero, forse se siprende in esame lo spot che il brand italiano Coop ha ideato nel 2017 in occasione della Giornata mondiale contro l’HIV pare che il tanto agognato futuro senza stereotipi per la comunità lgbt+ sia ancora una meta lontana.
RAINBOW WASHING e comunità LGBT+ solidarietà? E invece no!
Lo spot che all’apparenza parrebbe propinare al pubblico il classico stereotipo della promiscuità degli omosessuali e l’esclusiva (erronea) associazione dell’HIV agli stessi è in realtà soltanto uno spot veramente molto brutto. E non sono soltanto gli appartenenti alla comunità lgbt+ a decretarlo nell’apposita sezione commenti di Youtube, ma anche gli eterosessuali nella sezione commenti degli altri due spot stavolta indirizzati ad essi. E infatti all’interno del canale YouTube dell’azienda, nella cartella del progetto, appaiono altri due spot che stavolta ritraggono in situazioni analoghe degli eterosessuali.
Tutto lascia presagire che più che un problema di stereotipi, in questo caso si parli di un problema di scelte artistiche poco condivise.
La verità è che negli ultimi anni i brand sono andati incontro ad una rivoluzione del modo di rappresentare la comunità lgbt+. Non sono poi così lontani gli anni in cui essi evitavano di essere associati al movimento (accadeva fino a prima degli anni ‘70) o quelli in cui le pubblicità, per cattiva informazione, restituivano al mondo un quadro distorto di queste persone. Dagli anni ‘70 i marchi hanno realizzato che con i loro limitati orizzonti stavano escludendo dai guadagni una lucrosa fetta di mercato e da quel momento hanno fatto in modo che la crescente apertura della società nei confronti delle minoranze li guidasse ed educasse col fine di venire incontro agli standard crescenti di consumatori sempre più consapevoli.
Un esempio di RAINBOW WASHING e comunità LGBT+
I brand hanno iniziato ad assorbire sempre più le impressioni suscitate dai loro spot nella comunità lgbt+, perfezionandosi di volta in volta. Risale solo a due anni fa il commovente spot inglese della Renault che sulle note di una cover di Wonderwall degli Oasis ripercorre le tappe della travagliata storia d’amore di due donne, suscitando l’empatia anche dei più diffidenti per la delicatezza e purezza con le quali il sentimento viene trattato.
Per una rappresentazione più completa è giusto citare anche un esempio di spot che mostri la porzione più eccentrica della comunità (che non va eretta a modello assoluto, certo, ma neanche ignorata): “Fifty Years Proud” del brand newyorkese Coach ne è un esempio.
In questo spot i protagonisti sono artisti transgender (persone che non si riconoscono nel sesso attribuitogli alla nascita, bensì in quello opposto) che celebrano con il loro talento, la loro energia e i loro outfit appariscenti i cinquant’anni del Pride. Ma se sul fronte della rappresentazione i brand hanno fatto passi in avanti, sul piano della concretezza la strada da percorrere è ancora lunga. L’ARMA DELLA CONSAPEVOLEZZA.
Rappresentare la comunità lgbt+ negli spot pubblicitari è importante
poiché concorre ad educare le persone in merito alle differenze di sesso e di genere (che sono due cose distinte). Ma lanciare un bel messaggio e non contribuire in alcun altro modo alla causa (soprattutto se ce ne sono ampiamente i mezzi), facendo, cioè, del rainbow washing, non ha che la stessa valenza di una dritta impartita ad un figlio laddove è lo stesso genitore a non metterla in pratica.
I brand hanno optato per questa pigra (ma conveniente) strategia a lungo.
E lo hanno fatto indisturbatamente finché qualcosa nelle coscienze dei consumatori non ha iniziato a smuoversi. Perché sì, il tipo di consumatore al quale i marchisi rivolgono oggi è cambiato. O meglio, sta cambiando. E potremmo tranquillamente individuare l’origine di tale progresso nella più scolarizzata ed istruita delle generazioni: la generazione Y (dei cosiddetti “millennials”, nati tra gli anni ‘80 del 1900 e il 2000).
In qualche modo lo sguardo pare non più puntato esclusivamente sul prodotto venduto o sul nome del brand, ma sulla sua onestà (il supporto nei riguardi della comunità si fa sentire soltanto nel mese del Pride o tutto l’anno?), sulle sue politiche aziendali (tra le fila dei dipendenti ci sono membri della comunità lgbt+? Vengono retribuiti in maniera equa?), sui profitti (parte del ricavato va ad organizzazioni lgbt+ o i brand mantengono solo degli sterili rapporti di partnership con le suddette? Nel primo caso, in che percentuale?).
Splendido esempio di questa crescente consapevolezza è fornito dal numero sempre maggiore di youtubers che affrontano la tematica dando anche consigli su come testare la sincerità dei brand (Rowan Ellis ne è un esempio). Così come le email degli utenti di Twitter inviate al marchio Calvin Klein in attesa di chiarimenti circa la “Pride Collection” e la percentuale degli incassi che sarebbe stata donata alle organizzazioni lgbt+ dopo la vendita di quella merce, per poi scoprire che no, le donazioni del marchio non sarebbero dipese direttamente dall’andamento delle vendite di quest’ultima.
Mi piace pensare che questa consapevolezza possa soltanto aumentare fino a divenire pura normalità presso le generazioni future. In questa consapevolezza ci vedo un messaggio per tutti i brand:vi teniamo d’occhio!
IL BICCHIERE NON È SEMPRE MEZZO VUOTO
Certo, potremmo star qui a parlare di come la meta sia ancora lontana (non avremmo interamente torto), ma questo è fin troppo semplice. Parliamo piuttosto del fatto che nel 2021 i brand abbiano necessità d’apparire inclusivi per poter continuarea vendere o peggio, a esistere (il marchio Barilla è quasi fallito per aver dichiarato la sua posizione intransigente nei confronti della comunità lgbt+).
Ma soprattutto, per una volta, concediamoci di rallegrarci per il fatto che se i marchi attenti ai consumatori sono sempre più interessati ad un tema sociale come l’inclusione, forse è perché infondo non si è poi così tanto ignoranti e insensibili all’argomento come un tempo.
Donatella Di Giulio Cesare
Leggi anche: Praticare il blackface è ignoranza o razzismo?